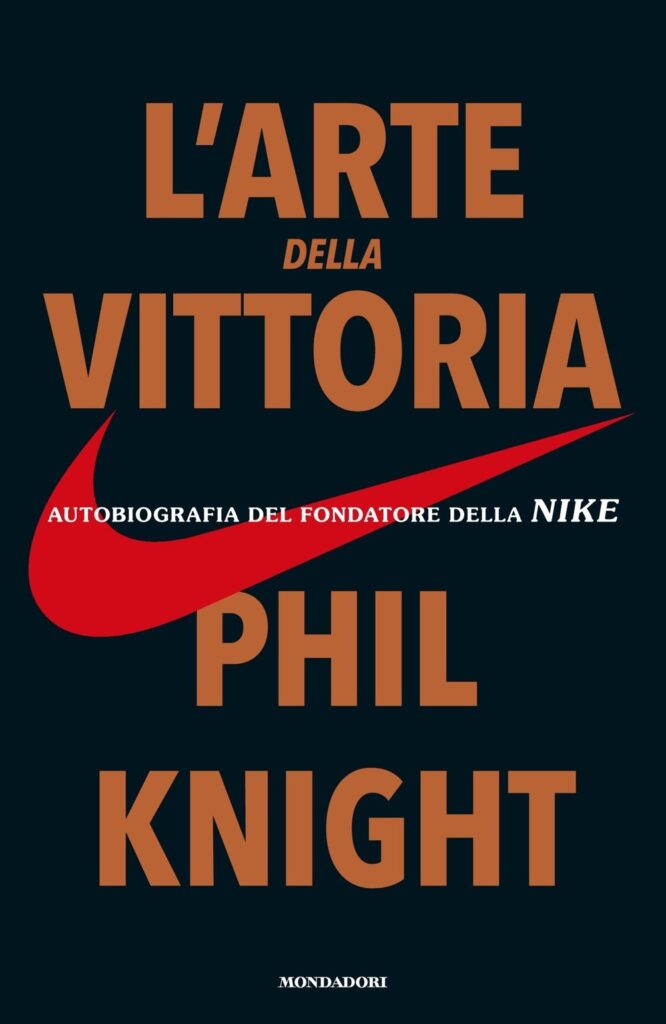Tutti conosciamo il marchio Nike, famoso in tutto il mondo, ma pochi sanno la storia del suo fondatore, Phil Knight.
Nasce a Portland il 24 febbraio del 1938 e si laurea nel 1959 in contabilità presso l’Università dell’Oregon. Finita l’università, sente l’esigenza di viaggiare per il mondo e nel novembre 1962 si trova a Kobe in Giappone, dove incontra il proprietario dell’azienda Onitsuka Co. che produce le famose Tiger, scarpe da corsa di qualità e dal basso costo. Dopo aver pian piano guadagnato la loro fiducia, riesce a distribuire queste scarpe negli USA, ma parallelamente, insieme al suo socio ed allenatore Bill Bowerman, inizia a studiare il mercato delle scarpe sportive, cercando di apportare miglioramenti ed innovazione e, grazie all’intuizione del suo primo impiegato in azienda, Jeff Johnson, viene scelto “Nike” come nome dell’azienda nascente, ispirandosi alla dea greca della vittoria alata. Ma accanto al nome Nike occorre un logo che sia al tempo stesso d’impatto ma semplice da ricordare. Nasce così il mitico logo Swoosh, una virgola capovolta e orizzontale, creato da una studentessa di graphic designer, Carolyn Davidson, e commissionato per soli 35 dollari.
Il libro ‘Larte della Vittoria’ è una delle biografie più belle mai lette, edito da Mondadori, con un’introduzione che merita di essere riportata, almeno in parte in questo articolo.
“Tendevo a soffermarmi su tutte le cose che non ero. il motivo era semplice. Erano le cose che conoscevo meglio.
Mi sarebbe stato difficile dire chi o che cosa fossi di preciso, o che cosa sarei potuto diventare. Come tutti i miei amici aspiravo al successo. A differenza di loro non sapevo che cosa significasse. Soldi? Forse. Una moglie? Dei figli? Una casa? Certo, se avessi avuto fortuna. Erano questi gli obiettivi ai quali mi era stato insegnato ad aspirare, e una parte di me era a quello che aspirava, istintivamente. Ma nel profondo cercavo qualcos’altro, qualcosa di più. Avevo la penosa sensazione che il nostro tempo fosse breve, più breve di quanto pensassimo, breve come una corsa mattutina, e volevo che il mio avesse un senso. E uno scopo. Che fosse creativo. E importante. Ma, soprattutto… diverso.
Volevo lasciare un segno nel mondo.
Volevo vincere.
No, non è esatto. Semplicemente, non volevo perdere.
E poi è successo, Mentre il mio giovane cuore iniziava a martellare, i miei polmoni rosei si allargavano come le ali di un uccello e gli alberi diventavano indistinte macchie verdastre, mi passò davanti agli occhi, con assoluta chiarezza, quello che volevo fare della mia vita. Un gioco.
Si, pensai, ecco. Questa è la parola giusta. il segreto della felicità, l’avevo sempre sospettato, l’essenza della bellezza o della verità, o tutto ciò che dobbiamo sapere di entrambe, sta in quel momento in cui la palla è a mezz’aria, quando i due pugili sentono avvicinarsi il suono della campana, quando i corridori sono prossimi al traguardo e la folla si alza come un corpo solo. C’è una sorta di esuberante chiarezza in quel fremito, mezzo secondo prima che si decidano la vittoria o la sconfitta. Quella, qualunque cosa fosse, doveva essere la mia vita, la mia esistenza quotidiana. In quel momento, percorrendo un miglio dopo l’altro in sei minuti, mentre il sole nascente incendiava gli aghi più bassi dei pini, mi chiesi. E se ci fosse un modo, senza essere un atleta, di provare ciò che provano gli atleti? Di giocare tutto il tempo, Invece di lavorare? O di lavorare con un gusto tale da farne essenzialmente la stessa cosa?
Il mondo era tormentato a tal punto dalla guerra, dalla sofferenza e dalla miseria, il tran tran quotidiano era così spossante e spesso iniquo che forse, pensai, l’unica soluzione era trovare un sogno prodigioso, improbabile, che sembrasse degno, divertente, adatto, e perseguirlo con la totale dedizione e determinazione di un atleta. Che ci piaccia o meno, la vita è un gioco. Chi nega questa verità, chi si rifiuta di giocare, rimane a bordo campo, e non era quello che volevo. Più di tutto era quello che non volevo. Il che mi riportò, come sempre, alla mia Idea Folle. Forse, pensai, ma solo forse, dovrei riprenderla in considerazione.
Forse la mia Idea Folle potrebbe… funzionare?
Forse.
No, no, pensai, correndo più veloce, sempre più veloce, correndo come se stessi inseguendo qualcuno e fossi inseguito allo stesso tempo. Funzionerà. Per Dio, la farò funzionare. Niente forse.
All’improvviso sorridevo. Ridevo quasi. Madido di sudore, muovendomi con una grazia e una levità che non avevo mai avuto, vedevo la mia idea Folle che brillava davanti a me e non sembrava per niente folle, Non pareva nemmeno un’idea. Pareva una persona, una forza vitale che esisteva molto prima di me, distinta da me, eppure parte di me. Che mi attendeva, ma al tempo stesso si nascondeva da me. Potrà suonare un po’ enfatico, un po’ folle. Ma era ciò che provavo in quel momento.
Ouel che rimane, però, è questa confortante certezza, quest’unica salda verità che non se ne andrà mai. A ventiquattro anni avevo un’Idea Folle, e in qualche modo, pur frastornato dall’angoscia esistenziale, dai timori per il futuro e dai dubbi su di me, come capita a tutti i giovani uomini e donne di quell’età, decisi che il mondo è fatto di idee folli. La storia è una lunga processione di idee folli. Le cose che amavo di più – i libri, lo sport, la democrazia, la libera impresa erano iniziate come idee folli.
Del resto, poche idee sono folli come la mia attività preferita, correre. È dura. Ingrata. Rischiosa. Le ricompense sono poche e tutt’altro che garantite. Quando corri su una pista ovale o lungo una strada deserta, non hai una destinazione reale. Quantomeno, nessuna che giustifichi appieno un tale sforzo. E l’atto stesso a diventare la destinazione, Non è soltanto che il traguardo non c’è; è che sei tu a definire il traguardo. I piaceri o il profitto che puoi trarre dall’atto di correre li devi trovare dentro di te. E tutta questione di come te lo presenti, di come lo vendi a te stesso.
Qualunque podista lo sa. Corri e corri, un miglio dopo l’altro, e non sai mai esattamente perché. Ti racconti che stai correndo verso un obiettivo, che stai inseguendo una qualche sensazione esaltante, ma in realtà corri perché l’alternativa, fermarti, ti spaventa a morte.
Così quella mattina del 1962 mi sono detto: lascia che gli altri definiscano folle la tua idea… tu prosegui per la tua strada. Non ti fermare. Non pensarci neanche di fermarti finché non arrivi là, e non stare a preoccuparti di dove sia «là». Accada quel che accada, tu non ti fermare, Ecco il consiglio precoce, profetico, urgente che riuscii a darmi, di punto in bianco, e che in qualche modo sono riuscito a seguire. Mezzo secolo dopo, sono convinto che sia il consiglio migliore – forse l’unico – che chiunque di noi dovrebbe mai dare.”
Quale vino ho scelto per il mio pairing? The corridor 2015, prodotto da The Authenthique Wine Cellars, proveniente dall’Oregon, terra natale del nostro protagonista del libro, distribuito in Italia da Pellegrini 1904 S.p.A.
Dal nome pensavo calzasse proprio a pennello, perchè ho pensato subito significasse “il corridore” invece si tratta di un “false friend”, una parola inglese che assomiglia molto all’italiano, ma che ha un significato completamente diverso, in questo caso “il corridoio”.
I vini prodotti da questa cantina hanno caratteristiche particolari perché provenienti dalla parte ovest dell’Oregon, che affiorata alla luce dopo essere rimasta sommersa nell’Oceano Pacifico per milioni di anni ed è una terra ricchissima di sedimenti vulcanici e marini. In quest’area è presente anche una tipologia di terreno vulcanico unica al mondo, chiamato “Jory soil”, particolarmente ricco in ferro nelle Eola-Amity Hills. Ciò che distingue le Eola-Amity Hills, AVA (American Viticultural Area) che si estende per quasi 30 km tra le colline di Amity a nord e quelle della città di Salem a sud, oltre alla tipicità del sottosuolo, è l’alternanza di giornate calde e notti fresche, con forti escursioni termiche dovute ai forti venti provenienti dall’Oceano Pacifico, che soffiano attraverso il “Van Duzer Corridor” (da qui l’assonanza con il nome del vino scelto).
Questo vino è un pinot nero sorprendente, pieno di note fruttate e delicate, con una struttura profonda e minerale, paragonabile a quella dei grandi vini della Côte de Nuits in Borgogna. Viene vinificato seguendo una settimana di macerazione e fermentazione spontanea in tini d’acciaio inossidabile e di quercia ed un successivo affinamento di 16 mesi in botti grandi e demi-muids da 600 litri.
Un vino molto elegante,e strutturato che al naso riporta un’ampia gamma di aromi di frutti di bosco, ciliegia, tè verde e dei fantastici sentori minerali. Non mancano le spezie, la vaniglia, ed una delicata nota floreale (rosa, violetta). Consigliato con piatti di carne rossa, cacciagione e selvaggina.
Buona lettura e buona degustazione.
Very Book Confidential. Very Wine Confidential.